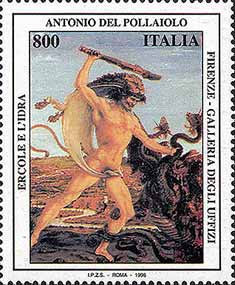Sicuramente un grande artista, il Pollaiolo, che a quest’ora fa venire voglia anche di un bel polletto, magari allo spiedo. Colgo l’occasione per proporre uno spunto che traggo da un libro che sto leggendo.
Il ritratto della gentildonna, una delle sue opere maggiori, per quanto di non certa attribuzione, è il classico esempio di rappresentazione rinascimentale. La donna pare essere colta non in un momento specifico, ma in una dimensione “metastorica”, priva, cioè, sia di un riferimento temporale, sia di una dinamicità che faccia supporre un movimento o uno stato d’animo contingente. Il rinascimento, infatti, è l’epoca di quel tipo di perfezione derivato dal mondo classico, che non ammette cambiamenti. Così, per esempio, erano i templi greci, concepiti con tutti gli accorgimenti ottici in grado di eliminare “fughe” prospettiche e quelle forme di movimento che violassero la perfetta immutabilità dell’ “Uno” parmenideo. Visitando un tempio greco, come una chiesa del rinascimento, si ha l’impressione che, tolta la costruzione, lo spazio interno debba rimanere cristallizzato sul posto, definito e misurabile come prima. Così è anche con la poesia, infatti durante il rinascimento prevale il sonetto, caratterizzato da una struttura compiuta in se stessa. Diverso è il caso del medio evo, dove le chiese gotiche offrono alla vista uno spazio che si riconfigura continuamente, muovendosi all’interno dell’edificio, e dove la poesia, si veda Dante, ha una costruzione che tende all’infinito. Così sarà anche nel barocco, per cui se si prende in esame un ritratto di Rembrandt, pare che il personaggio si animi, stia per muoversi o si sia appena mosso, sospinto da una pulsione interiore alla dinamica della vita.